L'ANALISI
22 Ottobre 2024 - 08:48

Nel riquadro Beatrice Del Bo, dietro la bottega di uno speziale medievale
CREMONA - Che rapporto c’è fra la strega di Biancaneve e Lucrezia Borgia? Chi erano gli speziali? Perché il veleno è abbinato alla figura femminile? Sono alcuni degli interrogativi a cui cerca di dare risposta Beatrice Del Bo, docente di Storia economica e sociale del Medioevo nel saggio, Arsenico e altri veleni. Una storia letale nel Medioevo, pubblicato da Il Mulino. Il volume sarà presentato il prossimo 7 novembre al Museo Archeologico in un incontro promosso dalla Società Storica Cremonese.
Arsenico e altri veleni richiama il film Arsenico e vecchi merletti di Frank Capra in cui Cary Grant scopre che le sue ziette, apparentemente le persone più dolci e tranquille del mondo, in realtà sono due pazze che assassinano la gente in nome di un malsano senso umanitario. «È uno dei miei film preferiti che mi diverte un sacco e che faceva al caso per questa mia storia sull’utilizzo del veleno nel Medioevo. L’obiettivo è stato quello di raccontare come il contatto col veleno fosse una cosa abbastanza abituale nell’Età di Mezzo e come alcuni luoghi comuni debbano però essere sfatati».
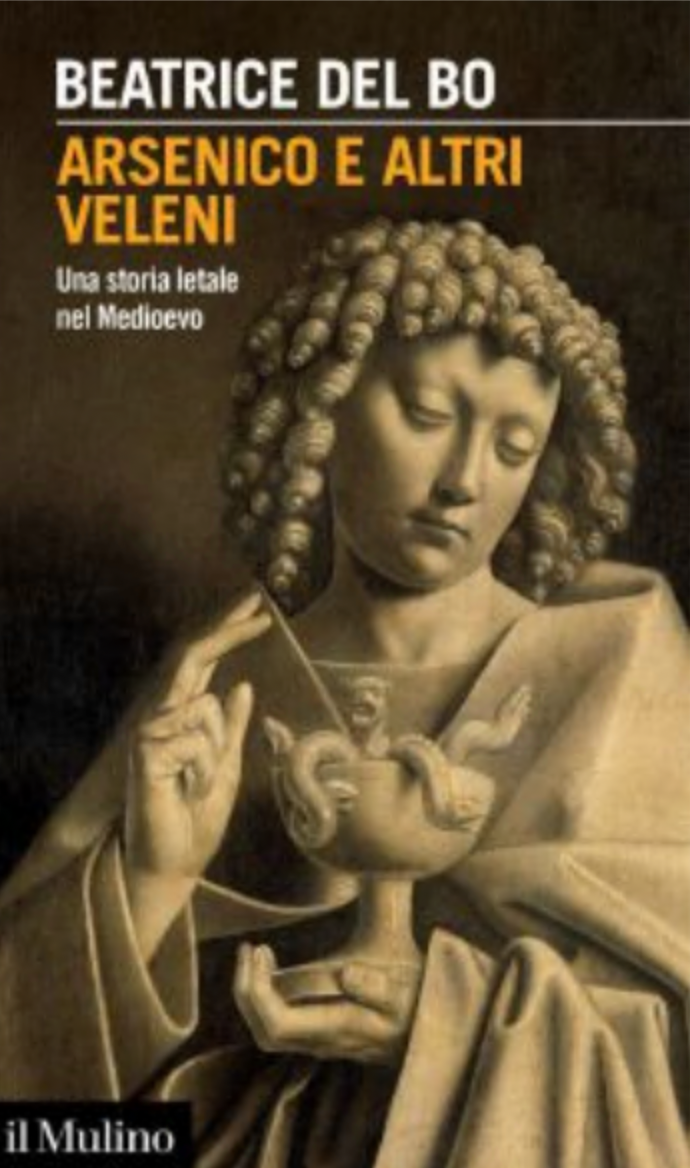
Uno di questi è il legame fra veleno e figura femminile?
«Un topos direi recente, che si sviluppa per causa di due personaggi e del racconto che ne viene fatto. Uno di questi è Lucrezia Borgia, presentata dagli avversari della famiglia Borgia e dai cronisti contemporanei come una perfida avvelenatrice e seduttrice. Nulla di più falso. Anzi Lucrezia Borgia fu donna dalle straordinarie doti diplomatiche e amministrative, a lei si deve la bonifica di buona parte del territorio ferrarese. Il mito di Lucrezia Borgia come donna seduttrice, lussuriosa e spietata avvelenatrice lo si deve, in epoca moderna, a Victor Hugo, prima, poi a Gaetano Donizetti e, infine, alla biografia scritta da Maria Bellonci del 1939. Due anni prima usciva il primo lungometraggio di Walt Disney, Biancaneve, in cui la regina trasformata in strega usa il veleno per uccidere la sua contendente. E tutto ciò in un contesto di favolosa ambientazione medievale».
Perché ha avuto così presa il binomio donna/veleno?
«Ammazzare tramite il veleno è una modalità subdola, adottata da chi non ha la forza fisica per un confronto e scontro diretto, ma usa i sotterfugi per raggiungere i suoi scopi. Il binomio donna-veleno si basa sulla natura irrazionale e debole delle donne, sulla loro inafferrabilità e inaffidabilità, caratteristiche messe in atto da una cultura di genere patriarcale, molto diffusa dal Rinascimento in poi. Ma credo che la narrazione sia un’altra e questo tento di dimostrare nel libro».
Quale è il rapporto col veleno nell’Età di Mezzo?
«I contatti con sostanze velenose erano all’ordine del giorno nel Medioevo. Il veleno faceva parte della quotidianità, anche in maniera accidentale. Avevano a che fare con sostanze velenose i tintori che maneggiavano allume, mercurio e l’arsenico per ottenere la colorazione verde. La stessa cosa vale per i pittori. Ma in fondo questo vale anche oggi, si pensi a cosa succede con i funghi velenosi. Ad esempio nel 2012 ci fu un caso in cui della mandragola, che è un’erba velenosa, venne venduta come spinaci. L’utilizzo del veleno era diffuso e trasversale a tutte le classi sociali nel Medioevo. Consultando le carte processuali non sono pochi i casi di avvelenamento anche fra gente comune. È questo il caso di Ambrogina che per ammazzare il marito chiede la complicità di un’amica che va da uno speziale a comprarle l’arsenico. La cosa buffa poi è che fu assolta per un’amnistia voluta dal Duca di Milano e Ambrogina visse vedova e felice».

Nel suo libro c’è un mondo che gira intorno al veleno, il mondo degli speziali e delle loro botteghe che noi immaginiamo come le antiche farmacie…
«Erano tutt’altro, erano luoghi di incontro e scambi culturali, ben lontani dall’immagine delle antiche farmacie. Lo speziale era, fra mercanti e commercianti, una delle figure più colte e istruite a cui i medici si affidavano. Allo speziale, appunto, si rivolgevano i medici per preparare le medicine. Lo speziale è l’antenato del farmacista, la sua arte lo poneva quotidianamente a contatto con il veleno per realizzare medicinali, farmaci. Nel significato della parola farmaco coesiste il significato di medicinale che cura e veleno che uccide».
Uno dei luoghi comuni è quello della presenza di assaggiatori alle tavole dei signori. Come legge questo fenomeno?
«Evidenziare questa minaccia era un modo per veicolare il messaggio di viltà dei nemici che non avevano il coraggio di affrontare de visu il signore. Ci sono casi di morte per avvelenamento, ma il ricorso agli assaggiatori poteva assumere un valore simbolico. Al tempo stesso morire avvelenati poteva voler dire che per sconfiggere il signore in questione si era dovuto ricorrere all’inganno e non allo scontro a viso aperto sul campo di battaglia».
C’è poi una sezione dedicata agli animali velenosi, reali o fantastici che fossero.
«Gli animali che avvelenano hanno un preciso significato simbolico, questo vale per il serpente, simbolo del maligno, ma anche per lo scorpione che avvelena con la coda, simbolo dei traditori. Non è un caso che i soldati che stanno ai piedi della Croce abbiano sul mantello giallo il simbolo dello scorpione. Anche i rospi, oltre a essere brutti e ripugnanti, sono velenosi e questo la dice lunga sulle povere principesse costrette a baciare un rospo per liberare il principe azzurro di turno. E poi si parla di sesso debole».
Ci sono poi gli animali che curano...
«Come la vipera e il suo veleno. La carne di vipera è l’ingrediente principale della teriaca, una sorta di intruglio destinato a curare diversi rimedi. Ci sono anche animali fantastici come l’unicorno a cui si credeva fermamente e il cui corno aveva proprietà taumaturgiche. Marco Polo dice di aver visto l’unicorno e lo descrive come basso, tarchiato e corpulento. Probabilmente vide un rinoceronte e ai suoi occhi quell’animale fu la dimostrazione dell’esistenza dell’unicorno».
Arsenico e altri veleni è una storia che vive di fonti diverse e variegate…
«Credo che piaccia per questo, siamo già alla prima ristampa. L’argomento piace e dopotutto gli avvelenamenti fanno sempre notizia, e raramente sono compiuti da donne, ricordiamocelo. Pensiamo all’avvelenamento di Alexander Litvinenko, ex spia russa e duro oppositore di Putin, a cui fu messo nel tè del polonio 210, un materiale rarissimo e altamente radioattivo. Putin ha fatto largo uso della strategia dell’avvelenamento per eliminare i suoi oppositori e non è certo una donna».
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris