L'ANALISI
04 Giugno 2024 - 05:25

Difficile definire una ‘brutta’ parola. La Treccani online, alla entry ‘Parolacce ed eufemismi’ curato da Lemma e Trifone, si pone il problema di ‘quando le parole diventano parolacce’. Le parole sono parole: non ce ne sono di belle o di brutte. Anzi: tutte sono belle. Sono come ogni espressione del Creato, come le piante, o gli animali: piacciono o meno, ma ciascuna testimonia la possibilità della capacità linguistico-relazionale dell’uomo. È l’uso a renderle più o meno adeguate a un ambito comunicativo, perché ciascuna di esse, e non solo le ‘parolacce’, possono, a seconda dei casi, più o meno volontariamente produrre nell’interlocutore un senso di fastidio, di disagio, o addirittura di offesa.
Fatta salva la chiara volontà di ferire, è più spesso nell’interrelazione soggettiva dei parlanti che un’espressione può essere sentita, dunque, come bella o brutta. La valutazione sta, da una parte, nella sensibilità del singolo, e dall’altra nella percezione sociale di ciò che è lecito e ciò che è proibito, un una sorta di senso del pudore esteso alla produzione linguistica. Quando la Garzanti, al ‘Parlo latino’ in uscita nell’ormai lontano 2004, chiedeva per questioni di uniformità di linea – modo altro per dire esigenze di mercato – di inserire un capitoletto sulle male parole, mentre io molto mi divertivo nell’essere autorizzato a profanare una lingua classica con espressioni al limite, se non, in qualche caso, oltre l’indecente, qualcuno si scandalizzò.
Lo stesso avvenne, un paio di anni dopo, per il ‘Parlo esperanto’. Se del primo si mirava, attraverso tale scelta, a mostrare l’attualità, il secondo emergeva in quello come lingua a tutti gli effetti, con tutti i diritti di qualunque altra. Perché senza le parolacce una lingua è incompleta… Giuseppe Antonelli, nel contributo dal titolo ‘Lingua’, in ‘Modernità italiana. Cultura, lingua e letteratura dagli anni Settanta a oggi’ (a cura di A. Afribo ed E. Zinato, Carocci, Roma), nel 2011 prendeva atto del fatto che il mondo ha ulteriormente accelerato il mutamento del sentire comune a riguardo: «Che ci piaccia o no, d’altronde, le parolacce fanno ormai parte del modo di esprimersi quotidiano e informale di quasi tutti gli italiani. Secondo uno studio del 2000, in televisione si sentivano 70-100 parolacce al giorno; secondo un altro del 2003, una ogni 21 minuti […]; nel film campione d’incassi Natale sul Nilo (2002) se ne contavano cento in cento minuti» (p. 45).
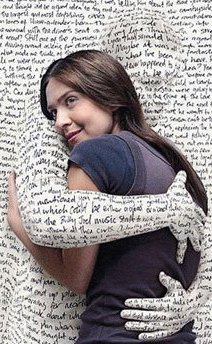
Il «senso del pudore linguistico» si andava, a detta di Antonelli, sempre più allentando, per tante ragioni che ci porterebbero lontano. Volete un esempio così da testare la vostra soglia di sensibilità linguistica? Già nel 1993, riportava Antonelli, la parola cazzo «risultava al 722° posto tra i vocaboli più ricorrenti nel parlato degli italiani (dopo notare e prima di verde […])». Nel Gradit online del 2018 s.v. ci sono citazioni da Anna Longoni, da Dacia Maraini e da Italo Calvino, secondo cui «ha un’espressività impareggiabile. Ed è un jolly linguistico» (da ‘Una pietra sopra: discorsi di letteratura e società’, Einaudi, 1980).
In un famoso saggio di Nora Galli de’ Parates, ‘Le brutte parole: semantica dell’eufemismo’ (I edizioni Giappichelli, Torino, 1964; poi Arnoldo Mondadori editore, 1969), l’interdizione verbale, come recita il sottotitolo, è «operata dall’inconscio, dal pregiudizio, dal pudore e dalla convenienza»: se una volta la censura funzionava su parole che riguardavano maggiormente il sesso, oggi l’attenzione si va spostando sul politicamente corretto, garantendo comunque il criterio che il potere coercitivo sull’uso linguistico dipende in tanta parte dall’imposizione sociale. Per tornare al tentativo di definire cosa sia una parola brutta, potremmo tentare un’equivalenza con volgare. Ma con difficoltà, e con tanti distinguo. Non raramente resta il dubbio se davvero la volgarità non stia più, come afferma la saggezza popolare, negli occhi di chi guarda, e si adatti ai costumi dei tempi; e, se non è dettata da ignoranza, è comunque sempre alla ricerca di un senso, di una finalità espressiva.
Vi va di farvi scandalizzare ancora un po’? Questo leggete del celebre buffone di corte Dolcibene de’ Tori nella Rima CXXIIb, 9 di Franco Sacchetti: «Ch’io ho il cazzo mio, ch’è tanto vano / che dorme su’ coglioni, e non si desta, / ed è cinq’anni o più che non fu sano». E che dire, lasciando la letteratura per il disegno, di alcuni bozzetti leonardeschi che, come testimoniava il pittore-scrittore cinquecentesco Giampaolo Lomazzo, fra gli altri, rappresentavano un ‘bellissimo fanciullo, co’l membro in fronte e senza naso, e con un’altra faccia di dietro della testa, col membro virile sotto il mento, e l’orecchie attaccate a i testicoli, le quali due teste avevano le orecchie di fauno; e l’altro mostro aveva in cima del naso il membro?’. Tentiamo allora con un equivalente quale ‘violento’. E riflettiamo su una frase come questa: «Non vali niente. Sei inutile».
Nessuna brutta parola in sé, ma il contenuto è estremamente aggressivo. Oppure ancora: «Mi ricorda Botero». Raffinata, quasi elegante, come offesa. Perché una parola si trasformi in un insulto si presuppone la volontà di insultare. In qualche caso – e la cosa è meno rara di quello che si pensa – il dolore che si produce nasce da fraintendimento, dovuto a tante possibili cause, fra cui, almeno, tra le più ricorrenti, l’imperizia di uso di chi si esprime in modo involontariamente infelice, ma, ancora, la particolare sensibilità di chi si sente in qualche modo direttamente coinvolto e ferito. Secondo Umberto Eco, «quando una lingua si libera di alcuni tabù si raggiunge uno stato di nuova innocenza».
Lo scriveva in una bustina di Minerva del 1999 ‘Sul cazzeggio’, dove proseguiva con questo tono: «Ormai da tempo non solo i ragazzi ma anche buona parte dei loro genitori credono davvero che ‘casino’ voglia dire soltanto ‘rumore’ o ‘disordine’, e anche persone di rango dicono ‘fichissimo’ di un bel ragazzo, avendo completamente dimenticato che il termine mascolinizza un pesante apprezzamento una volta usato per il sesso opposto. C’è quindi la possibilità che la prossima generazione ritenga in buona fede che ‘cazzo!’ voglia dire soltanto ‘perbacco!’ e che ‘cazzeggio’ sia un sinonimo di ‘chiacchiericcio’ già raccomandato dal Tommaseo». Come avvertiva Roland Barthes, «nessun linguaggio è innocente». Per usarlo bene ci vuole consapevolezza.
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris