L'ANALISI
VERSO IL VIAGGIO DELLA MEMORIA
04 Febbraio 2025 - 08:32

Tristano Matta, Tatiana e Andra Bucci e Paolo Gualandris sul palco del Ponchielli (FOTOLIVE/Paolo Cisi)
CREMONA - «È stato lì, in quella stanza piena di giocattoli, che ho capito che potevo lasciare andare mia sorella. Non ricordo se me lo avesse detto la mamma, ma mi sentivo responsabile di Andra e ho sempre cercato di proteggerla»: la vita, ce la si può riprendere in mano anche tra «una casa delle bambole e un cavallo quasi grande come uno vero», tanto più a 8 anni, dopo nove mesi prigioniera a Birkenau e un anno di orfanotrofio a Praga. Tatiana e Andra Bucci sono tra i pochi minori sopravvissuti ai Lager nazisti: solo ad Auschwitz, di cui Birkenau era un sottocampo, ne sono stati deportati oltre 230mila e il 27 gennaio del 1945, all’arrivo dell’Armata rossa ce n’erano meno di settecento.

Testimoni attive della Shoah, con uno sguardo rimasto bambino, le sorelle Bucci ieri hanno incontrato gli studenti che parteciperanno al prossimo Viaggio della Memoria organizzato dalla Rete scuole. Ponchielli gremito, silenzioso e attento - ma perché ci si stupisce che i ragazzi siano partecipi? - Tati e Andra hanno raccontato di loro e della loro mamma, del cuginetto Sergio De Simone, 8 anni appena, «impiccato a un gancio da macellaio, appeso come un quadro il 20 aprile del ’45, il giorno del compleanno di Hitler» e dell’altro cugino Silvio, morto a Bergen Belsen tra le braccia della mamma e «dopo aver sofferto così tanto che la zia disse: ‘finalmente’».
L’incontro è stato introdotto da Ilde Bottoli, referente storica della Rete scuole: «Da ventotto anni organizziamo il Viaggio della Memoria grazie a tutti coloro che ci sostengono». Andrea Cigni, sovrintendente del Ponchielli, ha ricordato che «il teatro è la casa di tutti, è il luogo del racconto e dell’ascolto». Luciano Pizzetti, presidente del Consiglio comunale, dopo aver chiesto un minuto di silenzio in ricordo di Elisa Marchesini, ha ricordato che «Cremona è una città che ha dato un contributo importante alla guerra di Liberazione, ma è anche la città di uno dei peggiori ras del fascismo, Roberto Farinacci. La Shoah è stata un crimine contro l’umanità e non si può emendare».

«Quando avete deciso di raccontare quello che avete vissuto», chiede Paolo Gualandris, direttore del quotidiano La Provincia che ha condotto l’incontro. «Non c’è stato un momento preciso - risponde Tati -, ma per molto tempo nessuno ci ha voluto ascoltare. Anche a nostra madre dicevano: ‘Miretta, dove sei stata?’. Lei lo diceva, ma non le credeva. È successo anche a Sami Modiano, a Shlomo Venezia, a Pietro Terracina, a quasi tutti. La guerra era appena finita, era stata dura per tutti. Niente di paragonabile a chi ha vissuto la Shoah, però nessuno voleva ascoltare. L’attenzione è cresciuta negli anni, soprattutto da dopo che è stata istituita la Giornata della Memoria».

Andra ricorda invece il viaggio verso Auschwitz, il vagone stipato, il secchio in un angolo per i bisogni fisiologici: «Alcune donne avevano portato delle coperte da casa, riuscivano a garantire un po’ di privacy. Soprattutto le donne più anziane erano molto a disagio, bisogna andare indietro di più di ottant’anni, c’era un senso del pudore diverso». E poi l’arrivo al Lager, il lungo percorso a piedi, «ma non mi ricordo di essermi stancata», e «una fila di alberi bellissimi». Alla prima selezione, la nonna viene mandata subito alla camera a gas, Tati e Andra, scambiate per gemelle, finiscono al Kinderblock dove Josef Mengele, il medico del campo, fa i suoi esperimenti scellerati. Quando anni dopo le sorelle Bucci torneranno a visitare il Lager «c’erano l’erba alta e i fiori, le farfalle. Noi di Birkenau ricordiamo il freddo e la neve, l’erba non è mai cresciuta neppure in primavera».
Al Kinderblock arriva anche Sergio, «un bambino bellissimo, i capelli e gli occhi neri e la carnagione un po’ scura presa dal papà napoletano». Non ce la fa, però, Sergio, a seguire il consiglio delle cuginette. ‘Qualsiasi cosa vi chiedano - dice loro una blockova, una guardiana che si è affezionata alle due bambine italiane -, non muovetevi’. Ma Mengele chiede ai bambini di fare un passo avanti se vogliono vedere la mamma. Sergio quel passo avanti lo fa e insieme ad altri diciannove bambini finisce a Neuengamme dove i medici nazisti lo usano come cavie. Finiranno tutti appesi a dei ganci e «qualcuno era così leggero che è stato tirato per le gambette», ricorda Tati. È stato un giornalista tedesco, Günther Schwarberg, a raccontare la storia di quei bambini, a lottare perché la memoria di quelle piccolissime vittime non andasse perduta.
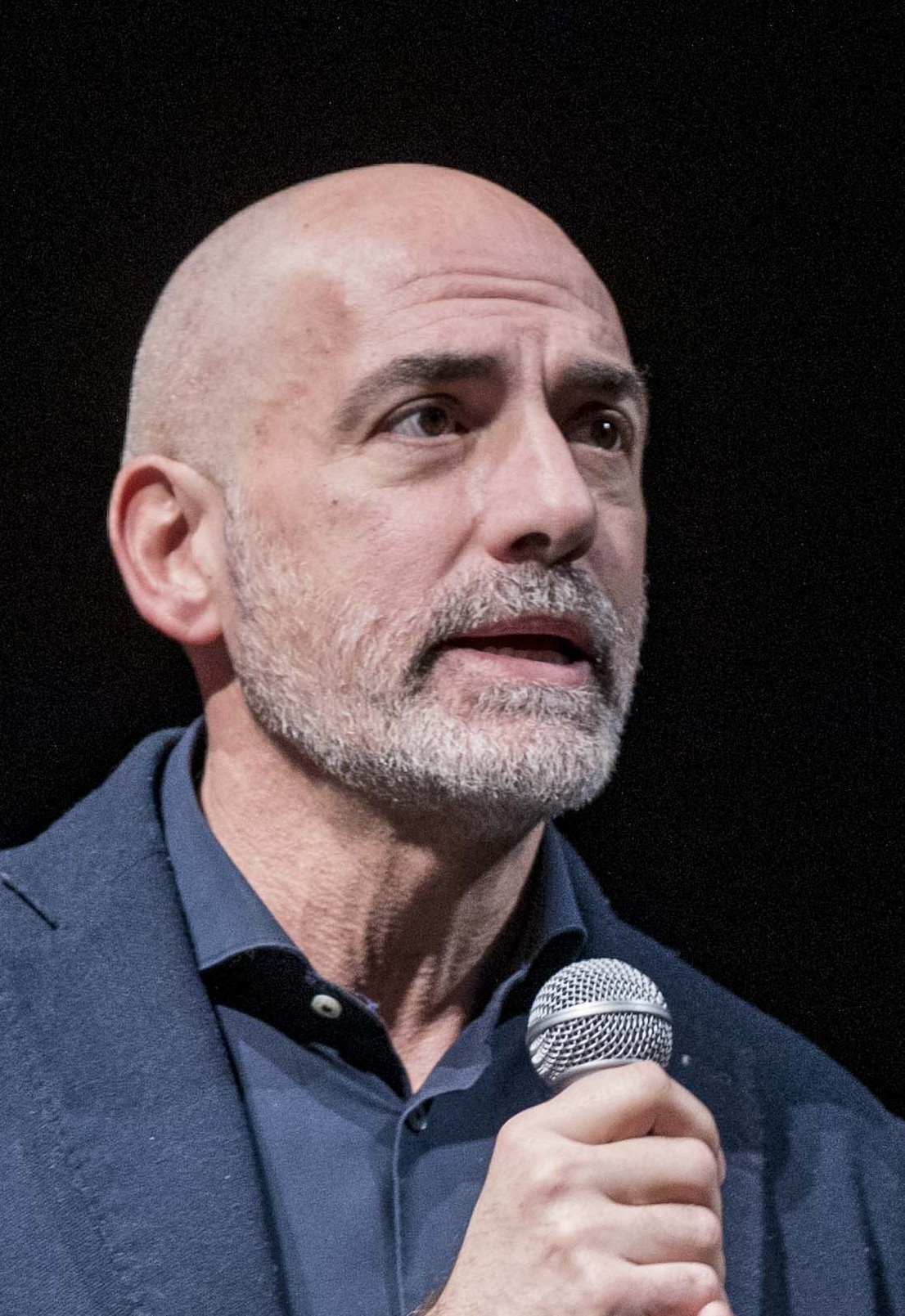
«Conoscendo Günther - è sempre Tati a parlare - ho capito la differenza tra i tedeschi e i nazisti». Andra parla invece della vita al campo: «Fuori dalla nostra baracca c’erano delle pile di cadaveri e formavano delle piramidi - dice -. Ricordo che erano bianchissimi, ho saputo dopo che per evitare infezioni i nazisti cospargevano i morti di calce. Non ci facevano impressione, era diventata una cosa normale giocare attorno ai morti. In un’altra baracca venivano messi i deportati morti durante la notte, era sempre talmente piena che non si riusciva neppure a chiudere la porta. Ma noi eravamo molto piccole, non avevamo neppure paura della morte. Gli adulti hanno sofferto di più». Un lampo di umanità è una scatola di latta piena di biscotti che Tati riceve da un nazista: «Forse - ammette - la stessa persona era capace di uccidere a sangue freddo un deportato».
La mamma, però, è stata determinante per il successivo, tardivo ricongiungimento. «Appena le era possibile - dice Tati - veniva a trovarci, ci ripeteva i nostri nomi. Io per esempio mi chiamo Liliana all’anagrafe, me lo ricordava sempre insieme al cognome e alla nostra città di origine». Dopo la liberazione di Auschwitz Tati e Andra sono state per alcuni mesi in un orfanotrofio vicino a Praga e in seguito hanno raggiunto Lingfield in Gran Bretagna, dove Anna Freud ha allestito una specie di asilo/rifugio per bambini sopravvissuti alla Shoah. È (quasi) il ritorno alla normalità, all’affetto, al calore, all’umanità. Ai giocattoli dell’infanzia perduta.

«La Shoah è il crimine più grave della storia contemporanea - dice Tristano Matta inquadrando nel contesto storico la deportazione di Tatiana e Andra Bucci, originarie di Fiume -. Nella Germania nazista si inserisce in un Paese civile e colto, a dimostrazione di quali rischi corrono le democrazie. È un processo su basi eugenetiche che comincia molto gradualmente fin dagli anni Trenta. È con l’Operazione Barbarossa e l’espansione verso Est della Germania di Hitler che si registra un’escalation dei sistemi repressivi».
Dai ghetti ai campi di concentramento ai campi di sterminio la macchina nazista non si ferma. A essere perseguitati, arrestati, deportati e uccisi sono soprattutto ebrei, ma anche sinti e rom, oppositori politici, persone omosessuali. In Italia, «le leggi razziali che io definisco razziste - prosegue Matta - sono del 1938 e i cittadini ebrei diventano cittadini di serie B. È però nell’autunno del 1943, con l’occupazione nazista e con la nascita della Republica sociale che comincia la persecuzione vera e propria. Molti ebrei erano però riusciti a lasciare l’Italia: nel ’38 gli ebrei italiani erano 46mila, scesi a 39mila nel ’43».
Il territorio triestino-sloveno non è amministrato dalla Rsi, ma rientra nella cosiddetta Zona d’operazioni del litorale adriatico, sotto il controllo diretto del Reich. «A Trieste - spiega Matta - opera l’élite dello sterminio, a Trieste c’è l’unico campo, San Sabba, in cui è presente un forno crematorio. Le deportazioni continueranno fino alla fine, quando l’esercito di Hitler ha di fatto già perso la guerra. Andra e Tatiana Bucci e i loro familiari vengono arrestati il 28 marzo 1944 in seguito a una delazione. Dopo una breve permanenza alla Risiera di San Sabba, la famiglia sarà deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove il loro convoglio arriva il 4 aprile.

«Non ho mai provato odio. E poi nei confronti di chi? I nostri carcerieri sono morti, i tedeschi di oggi non hanno colpa per quello che è successo»: Tatiana Bucci risponde così alla domanda di una studentessa. «Neanch’io ho mai odiato - aggiunge Andra -, però dei tedeschi ho sempre avuto paura. Forse perché la mamma ci ripeteva che se un tedesco indossa l’elmetto e prende un fucile è disposto a uccidere anche la propria madre». E chiamata a rispondere dell’indifferenza che ha permesso la Shoah, la sorella Andra ammette che «molti sono stati indifferenti per paura, ma tanti hanno finto indifferenza perché ci credevano».
Potrà esserci un’altra Shoah?, chiede un’altra ragazza. «No, non ai livelli in cui è stata pianificata dai nazisti. La macchina dello sterminio è stata implacabile - dice Tati -, non credo che possa essere riproposta oggi». Sopravvissute al prezzo di sensi di colpa per avercela fatta? «Soprattutto nei confronti di Sergio - dice Andra - mi chiedo perché noi non siamo morte e lui invece non è tornato». «Io invece sensi di colpa non ne ho mai avuti - replica Tati -, è stata la vita a far sì che noi siamo qui e adesso siamo noi a testimoniare. Lo faremo sempre».
La cosa più difficile da raccontare o da far capire? «Raccontare la storia di Sergio per me è sempre difficile», risponde Tatiana. «Per me - sostiene la sorella Andra - non è facile far capire che eravamo solo delle bambine di 4 e 6 anni. Molte cose non le abbiamo viste o le abbiamo capite solo più tardi». Così come al ritorno in Italia, un paio di anni dopo la liberazione, quando Tati e Andra hanno incontrato i parenti dei bambini romani deportati dopo il rastrellamento del 16 ottobre 1943: «L’abbiamo capito solo dopo, noi non sapevamo nulla», dicono.
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris