L'ANALISI
17 Dicembre 2024 - 05:30

La tecnologia ci interpella. È una domanda che appartiene all’uomo di oggi, ma contraddistingue l’uomo da sempre, perché determina ogni stagione dell’umana vicenda, fin dal suo sorgere. Per questa ragione la tecnica è fenomeno epocale ed originario. Ci può essere tecnica senza uomo? E ancora: ci può essere uomo senza tecnica?
Oggi la specificità dell’umano è messa in discussione su due fronti: da un lato quello della sua differenza rispetto all’animale nel dibattito sull’anti-specismo e, dall’altro, quello della sua differenza rispetto alla macchina nel dibattito sull’intelligenza artificiale.
Circa il primo, la tecnologia gioca un ruolo importante nel processo di ominazione: l’uomo è capace di gesto e linguaggio, ‘tecniche’ fuori dalla portata dell’animale. Circa il secondo, la tecnica palesa lo spirituale dell’uomo: egli è capace di dare un significato simbolico all’artefatto, in un ambiente che trasforma in cultura.
Facciamo un esempio. Il bastone da passeggio della nonna è diverso da quello utilizzato dallo scimpanzè per raggiungere il casco di banane. A prima vista potrebbero assomigliare, ma poi ci accorgiamo che il primo è stato regalato dai nipoti, che c’è una dedica su targhetta… insomma, su di esso si iscrive la trama sociale che lo avvicenda.
Per comprendere la tecnologia dobbiamo sedere in compagnia degli uomini primitivi, domandando ospitalità intorno al loro focolare.
Rimarremmo stupiti nel vedere che, dopo avere preparato la cena cacciata con amigdale, cucinata con raschiatoi, si passa a dipingere le pareti di Lascaux: grotta che conserva la ‘cappella sistina’ preistorica. In questa scena emerge come la tecnica sia espressione dello spirito: mezzo per ordinare la materia e cogliere l’oltre del nostro destino. Vediamo come antropogenesi e tecnogenesi sono coestensive. Se, dunque, l’origine dell’uomo e l’origine della tecnica sono collegate, allora avversione alla tecnica è avversione all’umano.
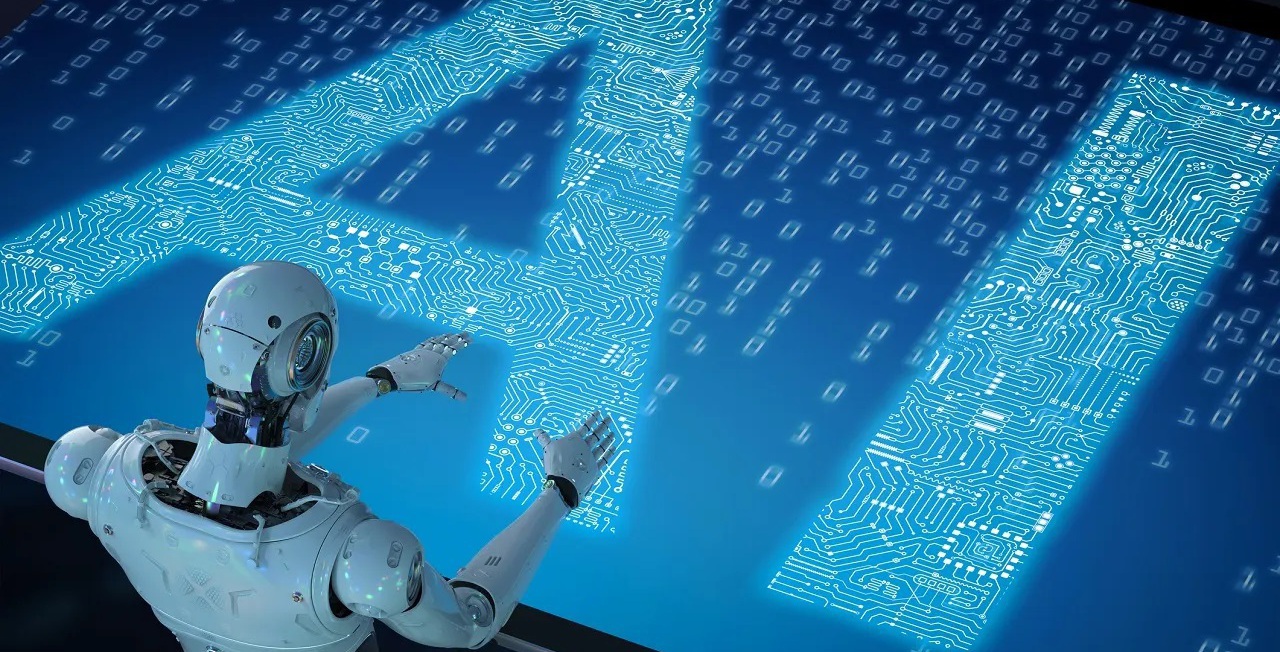
Tale impostazione evita il grande rischio che oggi abbiamo verso la tecnica: quello di essere acriticamente entusiasti (Techno-enthusiasm) o tecnofobici (Technophobia and Neo-Luddism). Meglio, allora, pensare alla tecnica come ambivalente. Già Platone definiva la tecnica come farmaco, potendo essere tanto tossica quanto curativa. La tossicità della tecnica è evidente oggi nella cosiddetta società iperindustriale dove tutto è automatizzato. Come si esegue un software, così anche la vita è eseguita automaticamente. I Big Data e la capacità computazionale portano alla profilazione utenti al punto che l’umano è estromesso dai processi decisionali (man out of the loop).
La soluzione, tuttavia, non è nell’abbandono della tecnica, ma nella ricerca del suo ‘valore spirito’ di cui l’uomo è capace. Essa si pone nella qualità’ ‘interessante’ della vita - se preferite ‘interessente’ – perché fa da cerniera tra l’uomo e il mondo. La prova? La tecnica evidenzia la qualità innovativa e non solo evolutivo adattiva dell’umano.
Torniamo a sederci intorno al focolare preistorico. Se prendiamo in mano l’amigdala ci accorgiamo che essa non solo espleta una funzione, ma risponde anche a un canone estetico: è simmetrica! Una volta utilizzata, non è abbandonata, ma conservata insieme agli altri artefatti; sarà poi trasmessa alle future generazioni, fatta oggetto di scambio, fatta ‘voce’ sviluppando un linguaggio. Ecco che lo spirito ha un supporto materiale: il passaggio che l’uomo fa dal saper-fare al sapere-simbolico (egli dà un nome all’oggetto, lo vende, regala, ruba...) si iscrive nell’artefatto e caratterizza anche il soggetto (che diventa rispettivamente inventore, commerciante, benefattore, ladro).
Ancora intorno a quel focolare qualcuno avrà domandato: «Chi ha paura del lupo?». Questa domanda ci riporta a quando eravamo bambini, a quando ancora eravamo aperti allo stupore e prudenti verso l’ignoto. Secondo alcuni, il lupo di oggi è la tecnologia. Come abbiamo detto, a volte è accompagnata da facili entusiasmi, altre da catastrofiche paure. Se facciamo un salto in avanti e dalla Grotta di Lascaux arriviamo a Gubbio, vediamo che San Francesco aveva capito che per trattare col lupo occorreva stupore e prudenza. Ha così riportato la pace a Gubbio. Ancora, l’approccio di San Francesco ci aiuta ad uscire da questi due estremi.
Abbiamo visto una delle differenze uomo-animale. Che dire rispetto all’uomo macchina? La teologia può qui aiutare educandoci al valore del tempo e alla nobiltà del lavoro umano. Riprendiamo il bastone della nonna. La tecnica inaugura la temporalità, permettendo alla storia di emanciparsi dalla biologia. In un’immagine: l’uso dell’artefatto segna il passaggio dall’ultima zampa di animale alla prima mano di uomo. In questo modo l’umano diventa attore della storia, oltre a essere vivente della biologia. Il tempo non è più ciclico, ma va verso un compimento.
Il rapporto tra lavoro e tecnica viaggia sul binario del compimento e del compito che Dio affida all’uomo di custodire e coltivare la terra (v. Gen 2,15). L’uomo partecipa all’opera creativa di Dio: la tecnica, dunque, fa parte della sua vocazione. La teologia rafforza la visione della tecnica come partecipazione alla libertà e al destino dell’uomo nel dramma della storia. Il lavoro umano dà un carattere nuovo alla materia, alle energie, alle forze del mondo nel momento in cui le intercetta. Una volta inserite nel suo spazio di azione, esse entrano a far parte dell’ambiente umano, diventano così cultura.
La tecnica palesa oggi più che mai la portata dell’agire umano, finalizzata a migliorare la sua vita, come a minacciarla sempre più radicalmente verso un’estensione che non risparmia l’intero pianeta (lo scienziato Oppenheimer, ‘father of the atomic bomb’, ne è l’epitome). L’uomo coglie la sua identità nell’attuazione di sé che è (anche) esercizio tecnologico. Egli conferisce un carattere nuovo al mondo dove la tecnica può essere farmaco positivo volta a ordinare il Creato.
In breve, la tecnica dà all’uomo un aumento di potenza finora impensabile. Tale ampiezza di manovra si innesta su una più radicale possibilità: Cristo amplifica lo spazio di azione del dramma della libertà umana, perché apre alla vicinanza e alla lontananza massime possibili tra Dio e l’uomo.
In questo quadro, tramite i corsi di Teologia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore offre agli studenti la possibilità non solo di ‘saper-fare’ – per essere ottimi professionisti – ma anche di ‘saper-pensare’ – per orientarsi al bene nel nostro tempo, per pacificare il nostro tempo. Questa è la mission della Cattolica, non a caso fondata da un discepolo di San Francesco: essere l’Università migliore per il mondo.
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris